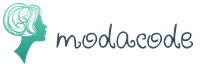Il coraggio come qualità della personalità è la capacità di mostrare volontà, fermezza morale, agire in modo deciso e opportuno in situazioni estreme e sopportare la sofferenza, compreso il dolore fisico.
C'è stato un caso in cui la moglie di un principe si è rivolta a Gengis Khan chiedendogli di liberare i suoi parenti. Gengis Khan disse: “Ecco, tuo marito, tuo figlio e tuo fratello stanno di fronte a te”. Ne lascerò andare solo uno, chi scegli? Senza esitazione, lei rispose: “Fratello”. - Mi spieghi perché? La donna disse: "Posso trovare un marito, posso dare alla luce un figlio, ma non posso creare un fratello". Dopo aver sentito questo, Gengis Khan li liberò tutti e tre.
Sia il coraggio che la codardia possono avere paura, la prima, di fronte a una pericolosa incertezza, si costringe a fare quello che dovrebbe e quindi si chiama coraggio, la seconda non ha avuto tempo, non ha potuto o non ha voluto fare da sola e dopo secondi tutto ciò che dovrebbe essere fatto è stato imposto da altre persone. Ecco perché si chiama codardia. Coraggio e codardia sono strettamente adiacenti e sono separati da un “muro di compensato”, situato nello spazio tra la paura del pericolo e la reazione ad esso. Sono questi momenti che mettono tutto in ordine, sono questi «momenti che danno vergogna ad alcuni, disonore ad altri e immortalità ad altri».
Il coraggio viene dalla mente, non dai sentimenti. Una persona coraggiosa, a livello riflessivo, si è allenata a svolgere i propri compiti in modo efficiente in qualsiasi cosa condizioni estreme, non ha lasciato ai suoi sentimenti una sola possibilità di temere, preoccuparsi, dubitare e fa con calma ciò che è necessario. Ebbene, che dire dei sentimenti? Puoi avere paura e preoccuparti più tardi se sorge il desiderio.
A differenza del coraggio, il coraggio implica responsabilità e razionalità. Non c’è coraggio senza connettere la mente. Il coraggio può essere impulsivo, può nascere dalla paura, anche un bambino può essere coraggioso, ma solo una persona ragionevole, volitiva, matura e olistica può essere coraggiosa. Il coraggio rivela la qualità della volontà accumulata. Nella testardaggine del bambino c’è anche la volontà, ma qual è la sua qualità?
Una persona coraggiosa non è solo coraggiosa, ma anche prudente. "Il coraggio senza prudenza è solo un tipo speciale di codardia", scriveva Seneca il Vecchio. Avendo sviluppato una visione responsabile, positiva e costruttiva del mondo, il coraggio afferma con sicurezza: "Sono responsabile di tutto ciò che accade nella mia vita". Non gli verrebbe mai in mente di scaricare la colpa su altre persone, circostanze, roccia malvagia, karma, eredità o sfortuna. “Sono in grado di superare tutte le difficoltà, imparare tutte le lezioni che la vita mi offre e accettare qualsiasi sfida del destino”, dice il coraggio, “Ciò che accade, non può essere evitato. Ogni problema ha una soluzione. È importante non perdere la presenza di spirito, ma pensare a cosa bisogna fare, per capire cosa guadagno dalla realizzazione di uno scenario negativo”. Il favorito del coraggio, Nikolai Ostrovsky, ha scritto: "La mascolinità viene coltivata giorno dopo giorno nella persistente resistenza alle difficoltà".
Una persona con una qualità così chiaramente dimostrata come il coraggio, di regola, è caratterizzata da autocontrollo, perseveranza, resistenza, dedizione e un maturo senso di autostima. Ci vuole coraggio sempre, ovunque e in ogni cosa. Un giorno un comandante chiese a un guerriero: “Che cosa è più necessario in battaglia?” Lui rispose: “Ciò che serve di più è il coraggio!” - E la forza e le armi? Oppure te ne sei dimenticato? - chiese il comandante. "Se non c'è coraggio nel cuore di un guerriero, né la sua forza né le sue armi lo aiuteranno", rispose.
"Un uomo coraggioso", secondo Pierre Boiste, "di solito soffre senza lamentarsi, ma un uomo debole si lamenta senza soffrire". Il coraggio non è un blocco di pietra insensibile; di solito si accompagna alla gentilezza di carattere, alla sensibilità speciale alle difficoltà e alle disgrazie degli altri e alla generosità. “Chi è pieno di misericordia avrà sicuramente coraggio”, scriveva Confucio . Una persona coraggiosa crede: "Una battaglia evitata è una battaglia vinta", non si vanterà della sua forza, al contrario, sarà tollerante e paziente con i difetti, i modelli di pensiero, le idee sbagliate e i pregiudizi degli altri.
L'incarnazione vivente del coraggio è il secondo ufficiale del Titanic, Lightoller. Disprezzando la paura, dopo che la nave si scontrò con un iceberg, lavorò sulla nave, organizzando il carico di donne e bambini sulle scialuppe di salvataggio. Anche nel momento critico, quando ha varato l'ultima barca, progettata per 47 posti, mentre sulla nave c'erano ancora 1600 persone condannate a morte, Lightoller non ha fatto il minimo tentativo di mettere lui stesso la rete su questa barca, sebbene aveva il diritto di farlo. Tuttavia, è meglio dare la parola a Walter Lord, l’autore del documentario “L’ultima notte del Titanic”: “Stando sul tetto delle cabine dello staff di comando, Lightoller ha visto quest’onda. Osservò come la folla di persone da lei guidate si ritirava verso l'alto lungo il ponte, come i più agili riuscivano a evitare il contatto con lei, e i più lenti non riuscivano a ritirarsi abbastanza velocemente e venivano inghiottiti dall'acqua. Lightoller capì che la ritirata della gente a poppa non faceva altro che prolungare l'agonia. Si voltò verso la prua della nave e saltò in acqua. Quando emerse, vide davanti a sé un "nido di corvo" (una piattaforma di osservazione sull'albero per le vedette), che ora era al livello della superficie del mare. Il cieco istinto di autoconservazione costrinse Lightoller a nuotare verso il “nido” per diversi secondi come luogo di salvezza. Ma presto tornò in sé e iniziò a nuotare lontano dalla nave finché non nuotò fino a una barca rovesciata ma galleggiante e si arrampicò sul suo fondo. Circa trenta persone salirono su questa barca, ma alcune di loro successivamente si congelarono e furono trascinate in acqua dalle onde. Dopotutto, quella notte la temperatura dell'acqua era di meno due gradi! Secondo testimoni oculari, è stato grazie alla compostezza di Lightoller che la maggior parte dei suoi compagni sono riusciti ad aspettare l’arrivo dei soccorsi. Il fatto è che l'aria continuava a uscire da sotto lo scafo della barca ribaltata e affondava sempre più in profondità nell'acqua. Di tanto in tanto un'onda si riversava sul fondo e qualsiasi movimento sbagliato di una persona poteva affondare la fragile barchetta. Allora il secondo ufficiale ordinò a tutti e trenta gli uomini di alzarsi, li formò in due file e li fece voltare verso la prua della barca. Quando iniziò a inclinarsi, ordinò alle persone di inclinarsi contemporaneamente in una direzione o nell'altra e quindi pareggiare il fragile equilibrio. Spostando il peso corporeo da una gamba all'altra, le persone congelate immerse nell'acqua ghiacciata non solo mantenevano a galla la loro "nave" capovolta, ma con questi movimenti si riscaldavano anche. Lightoller ha incoraggiato il suo equipaggio con messaggi sull’imminente arrivo dei soccorsi e, infatti, dopo più di un’ora di equilibrio sull’orlo della vita o della morte, sono stati notati e salvati dai rematori di altre barche”. Davvero il mondo rimarrebbe orfano senza coraggio!
Pietro Kovalev
Coraggio- una delle virtù che riflette la forza morale nel superare la paura. Il coraggio si riferisce spesso alla capacità di sopportare la sofferenza, compreso il dolore fisico.
Nell'antichità
In tempi nuovi
Durante la transizione verso una società industriale (tempi moderni), l’importanza del coraggio diminuisce, poiché “lo spirito industriale ha trionfato sullo spirito militare e aristocratico” (Nietzsche). Nell’etica moderna il coraggio diventa secondario o addirittura assume una connotazione negativa: ad esempio, Hobbes vede nella paura della morte una forza utile per instaurare la pace. Spinoza colloca il coraggio in fondo alla lista degli “affetti”. Secondo Kant il coraggio è la capacità di “osare ciò che il dovere impone”; Kant nota che la paura della derisione richiede più coraggio per essere superata che per combattere. Tra i famosi filosofi dei tempi moderni, solo Nietzsche ha tentato senza successo di ridare coraggio ruolo principale nell'etica.
Ora il coraggio è spesso usato semplicemente come sinonimo di fermezza morale universale, e perde il significato di virtù maschile (ad esempio, l'espressione “donna coraggiosa” in molte lingue – compreso il russo – non contiene contraddizioni). Ciò è facilitato teorie moderne ed esperienze pratiche di nonviolenza, dove la lotta nonviolenta è vista come più coraggiosa della lotta violenta (Mahatma Gandhi).
Negli affari militari
Guarda anche
Scrivi una recensione sull'articolo "Coraggio"
Appunti
Fonti
Estratto che descrive il coraggio
La nebbia diventava così forte che, nonostante fosse l'alba, era impossibile vedere a dieci passi davanti a sé. I cespugli sembravano alberi enormi, i luoghi pianeggianti sembravano scogliere e pendii. Ovunque, da tutte le parti, si poteva incontrare un nemico invisibile a dieci passi di distanza. Ma le colonne camminarono a lungo nella stessa nebbia, scendendo e risalendo le montagne, superando giardini e recinti, attraverso terreni nuovi e incomprensibili, senza mai incontrare il nemico. Al contrario, ora davanti, ora dietro, da tutte le parti, i soldati apprendevano che le nostre colonne russe si muovevano nella stessa direzione. Ogni soldato si sentiva bene nell'animo perché sapeva che nello stesso posto dove andava lui, cioè sconosciuto, stavano andando molti, molti altri dei nostri."Guarda, i soldati di Kursk sono passati", hanno detto tra i ranghi.
- Passione, fratello mio, che le nostre truppe si sono radunate! La sera guardavo come erano disposte le luci, non se ne vedeva la fine. Mosca: una parola!
Sebbene nessuno dei comandanti delle colonne si sia avvicinato ai ranghi o abbia parlato con i soldati (i comandanti delle colonne, come abbiamo visto al consiglio militare, non erano di buon umore e insoddisfatti dell'impresa e quindi eseguivano solo gli ordini e non si preoccupavano di divertire i soldati), nonostante i soldati camminassero allegramente, come sempre, entrando in azione, soprattutto in modo offensivo. Ma, dopo aver camminato per circa un'ora nella fitta nebbia, la maggior parte dell'esercito dovette fermarsi e una spiacevole consapevolezza del disordine e della confusione in corso si diffuse tra i ranghi. Il modo in cui questa coscienza viene trasmessa è molto difficile da determinare; ma quello che è certo è che si trasmette con insolita fedeltà e si diffonde rapidamente, impercettibilmente e incontrollabilmente, come l'acqua attraverso un burrone. Se l'esercito russo fosse stato solo, senza alleati, forse sarebbe passato molto tempo prima che questa coscienza del disordine diventasse una fiducia generale; ma ora, attribuendo con particolare piacere e naturalezza la causa dei disordini agli stupidi tedeschi, tutti erano convinti che ci fosse una dannosa confusione provocata dai salumieri.
- Cosa sono diventati? Tutto bloccato? O si sono già imbattuti in un francese?
- No, non ho sentito. Altrimenti avrebbe cominciato a sparare.
"Avevano fretta di parlare, ma quando sono partiti sono rimasti inutilmente in mezzo al campo: quei maledetti tedeschi stanno confondendo tutto." Che stupidi diavoli!
"Allora li avrei lasciati andare avanti." E poi, suppongo, si stringono dietro. Quindi adesso rimani lì senza mangiare.
- Allora, sarà lì presto? La cavalleria, dicono, ha bloccato la strada”, ha detto l’ufficiale.
“Oh, quei dannati tedeschi, non conoscono la loro terra”, ha detto un altro.
-In che divisione sei? - gridò l'aiutante mentre si avvicinava.
- Diciottesimo.
- Allora perché sei qui? Avresti dovuto essere avanti molto tempo fa, ora non ce la farai fino a sera.
- Quegli ordini sono stupidi; "Non sanno cosa stanno facendo", ha detto l'ufficiale e se n'è andato.
Poi passò un generale e gridò qualcosa con rabbia, non in russo.
"Tafa lafa, non puoi capire cosa sta borbottando", disse il soldato, imitando il generale defunto. - Gli sparerei, mascalzoni!
"Ci avevano detto di essere lì alle nove, ma non eravamo nemmeno a metà." Questi sono gli ordini! - ripetuto da diversi lati.
E il sentimento di energia con cui le truppe entrarono in azione cominciò a trasformarsi in fastidio e rabbia per gli ordini stupidi e contro i tedeschi.
Consideriamo un concetto così noto come "coraggio". Questa è un'immagine che risale alla notte dei tempi. Si è sviluppata riempiendosi di nuove sfaccettature. C’erano pensatori che cercarono di “rovesciarlo” e screditarlo. Ma non ne è venuto fuori nulla. Scopriamolo.
Il significato della parola "coraggio"
È chiaro che ora mettiamo dentro il significato che abbiamo ereditato. non sono creati in modo indipendente, sono iscritti in qualsiasi cultura come i suoi principali indicatori. Il significato lessicale della parola “coraggio” è estremamente chiaro. Questa è la capacità di resistere alle minacce che colpiscono i fondamenti della vita, inclusa la morte. Solo tutta la profondità questo concetto questa definizione non trasmette. Per capire, guardiamo il “percorso storico” della parola “coraggio”. Ciò ci consentirà di comprendere meglio ciò che è stato originariamente investito in esso e ciò che è compreso ora.
Come definivano il “coraggio” i filosofi antichi?
Molto spesso sono pieni di significati accettati nella società in cui operano. Nel mondo antico si credeva che il coraggio fosse l'eroismo dimostrato in battaglia. Ancora più semplice è la capacità di non aver paura della morte, che può derivare da un combattimento. Si scopre che solo i rappresentanti del sesso più forte e quelli che tengono le armi in mano potrebbero avere coraggio. Non è molto diverso da quello che pensiamo adesso? Tommaso d'Aquino ampliò il concetto. Credeva che questo favorisse la lotta per il bene. Riconosceva il coraggio come una virtù, sebbene la saggezza avesse la precedenza su di esso nel suo sistema.
Medioevo
In epoca cavalleresca, si sosteneva che il coraggio fosse una virtù militare. Solo un uomo armato poteva manifestarlo, poiché doveva superare se stesso quando entrava in battaglia con il nemico. Allo stesso tempo, alla gente comune, che ogni giorno affrontava la fame, il maltempo e altri pericoli, veniva negato il coraggio. Era attribuito solo ai ricchi e ai “nobili”, il che dal nostro punto di vista è molto strano.

Filosofia borghese
È chiaro che questo concetto era pieno di significato eroico. I filosofi cercarono di screditarlo sostenendo che il coraggio fosse una sorta di virtù secondaria. Hanno cercato di instillare nelle persone che la paura della morte è una forza produttiva che porta all'instaurazione della pace. I. Kant ha interpretato il coraggio come la capacità di fare ciò che dovrebbe essere fatto. Allo stesso tempo, il concetto stesso si è ampliato. È stato riconosciuto che il coraggio è più spesso necessario Vita di ogni giorno superare le barriere psicologiche e combattere circostanze sfavorevoli. Ad esempio, deve essere espresso da una persona vittima di bullismo o derisa. Nietzsche cercò di restituire al concetto il significato originario, ma i suoi tentativi non ebbero successo.
Aspetto moderno
Ripensare e trasformare interpretazioni diverse, ora la società concorda sul fatto che il coraggio è la forza dello spirito dimostrata da una persona di qualsiasi classe o genere nel superare vari tipi di pericoli. È ugualmente importante sia in battaglia o confronto che nella vita di tutti i giorni.

Una persona che ha paura mostra il massimo coraggio quando sale sul podio. Un decisore non è meno volitivo quando deve ammettere i propri errori. Una donna che teme il parto si sforza coraggiosamente di procreare. E così via. Ci sono molti esempi della manifestazione di standard etici nella vita. La filosofia comunista ci ha costretto a riconoscere che il coraggio è una qualità di ogni persona, e non di una certa “casta”. Lì si postulava che gli standard etici si applicassero equamente all’intera società, senza riguardo alle classi o ad altri tipi di gruppi di popolazione. Pertanto, il coraggio è una qualità che ti consente di mantenere l'equilibrio, il coraggio e la saggezza in ogni circostanza, per prendere e portare a termine una decisione equilibrata e ponderata, indipendentemente dai rischi.
Al giorno d'oggi si sente spesso parlare di coraggio. Inoltre, a volte questa qualità è dotata anche del gentil sesso. Ognuno di noi avrà la propria opinione se ciò sia giusto o sbagliato. Ti invitiamo a scoprire cos'è il coraggio e che aspetto ha un uomo coraggioso adesso.
Coraggio: che cos'è?
È generalmente accettato che una persona con questa qualità di carattere sia veramente forte e volitiva. Il coraggio è uno dei tratti positivi tutti, manifestati nella loro disponibilità a venire in aiuto non solo di se stessi e dei propri cari, ma anche degli estranei. Questa nobile qualità di carattere può manifestarsi in qualsiasi ambito della vita:
- un gruppo;
- Al lavoro;
- nella vita pubblica;
- in guerra.
Che aspetto ha il coraggio? Ognuno di noi ha la propria comprensione di quale azione possa essere considerata maschile. Tuttavia, la maggior parte degli uomini e delle donne tende a credere che un atto coraggioso si manifesti nel coraggio e nella volontà di sacrificare la propria vita per il bene degli altri. Un esempio di tale atto potrebbe essere il salvataggio di una persona durante un incendio o altro disastro naturale. Mentre per alcuni questo atto di coraggio può sembrare un normale passo umano, per altri è davvero un’impresa rispettabile.

A cosa serve il coraggio?
Alcune persone vivono bene senza, ma per altri è già diventato un principio di vita. Persone così coraggiose si trovano ovunque:
- Durante un disastro naturale. A volte puoi vedere quando persone che non sono molto forti fisicamente, ma davvero coraggiose, salvano coloro che sono nei guai.
- In guerra. Anche qui si può distinguere tra persone forti e coraggiose e codardi pronti a tradire un amico Tempi difficili.
- Nella vita di tutti i giorni. A volte capita che una persona sia in pericolo, ma solo pochi possono venire in soccorso e aiutare la vittima. Persone così coraggiose possono essere giustamente definite coraggiose.
Che tipo di coraggio c'è?
Si distinguono i seguenti tipi di coraggio:
- Psicologico– la capacità di una persona di vedere se stessa non per quello che realmente è, riconoscendo i suoi punti di forza e di debolezza. Il coraggio di una persona del genere gli permette di delineare una strategia per il suo sviluppo e la sua vita.
- Civile– la capacità di tutelare se stessi, nonché i propri diritti nella società, nel lavoro, in squadra. Queste persone non hanno paura di apparire diverse da tutti gli altri e di difendere i propri diritti.
- Combattivo o istintivo– la prontezza di una persona a litigare. Questa è, prima di tutto, un'abilità psicologica. Tale coraggio può essere innato, ma spesso viene corretto durante il percorso educativo. Qui molto dipende dai genitori e da tutte le persone che vi prendono parte.
Come diventare coraggiosi?
Succede anche che una persona non abbia tali qualità caratteriali, ma abbia il desiderio di imparare cos'è il coraggio, diventando più coraggioso e audace. Puoi sviluppare tali tratti in te stesso e diventare una persona veramente forte e volitiva. Per fare questo è necessario:
- Aumentare l'autostima.È chiaro che è improbabile che una persona insicura sia in grado di proteggere qualcuno e dimostrare agli altri che è una persona coraggiosa.
- Impara le arti marziali. Ciò sarà particolarmente vero per i ragazzi. Quindi, se un bambino con nei primi anni crescerà forte e sarà in grado di difendersi da solo, quindi non sarà un problema per lui proteggere gli altri.
- Impara a prenderti cura degli altri e di ciò che accade intorno a te. Queste persone non possono essere lasciate indietro se qualcuno è nei guai.

Coraggio nel nostro tempo
Puoi ancora incontrare una persona che è veramente pronta ad aiutare qualcuno in difficoltà. Il coraggio oggigiorno si dimostra non solo durante le operazioni militari, ma anche nella vita di tutti i giorni. Una persona coraggiosa non rifiuterà nessuno se gli chiede aiuto. Inoltre, a volte queste persone aiutano gli altri senza che gli venga chiesto, ma semplicemente vedendo un tale bisogno.
Ognuno di noi può citare molti esempi di come qualcuno che non ha uno speciale forza fisica una persona salva un bambino durante un incendio o protegge una vittima per strada. Inoltre, molto spesso in guerra si possono osservare azioni coraggiose, quando una persona è in grado di dimostrare di essere pronta a costo di Propria vita proteggerne un altro. Il coraggio è la qualità del carattere di una persona che supera ogni giorno le difficoltà della vita a beneficio dei suoi cari.
Cos'è il coraggio nell'Ortodossia?
L'Ortodossia parla positivamente di qualità come il coraggio e la nobiltà. Con tali qualità, la religione comprende il sacrificio, la capacità di una persona di venire in soccorso nei momenti difficili. Inoltre, questi termini non significano sfacciataggine o audacia. Una persona pronta a sacrificare molto per la sua famiglia può essere definita così coraggiosa. Quando una persona è pronta ad aiutare coloro che sono nei guai, può anche essere definita coraggiosa e persino un eroe. Per coraggio l'Ortodossia intende un benefattore, che consiste nel mostrare amore per gli altri.
Il coraggio in battaglia non è l’unica, e forse anche la più importante, forma di coraggio. C'è anche il coraggio di sopportare la povertà, il coraggio di sopportare il ridicolo, il coraggio di sopportare l'ostilità della folla. Qui anche i soldati più coraggiosi si trovano spesso in una situazione miserabile. E, soprattutto, c'è il coraggio di pensare con calma e moderazione di fronte al pericolo, frenando l'impulso paura del panico o rabbia.
Ottima definizione
Definizione incompleta ↓
CORAGGIO
virtù, che caratterizza la misura morale nel superare la paura; una delle quattro virtù cardinali dell'Antichità (insieme a moderazione, saggezza e giustizia). Aristotele ha fornito un'analisi sistematica del coraggio. Secondo lui il coraggio è il superamento del dolore fisico, dell'orrore e della paura della morte, stimolato da motivazioni morali. Non stiamo parlando di tutta la morte, perché può verificarsi per cause che sfuggono al controllo dell'uomo (malattie, incidenti), e non di tutte le cose legate all'orrore mortale, perché alcune di esse (incendi, tempeste, ecc.) sono ugualmente sono terribili per tutti e la paura di essi è una reazione umana normale e sana. Il tema del coraggio è la morte, che è considerata degna, bella e l'atteggiamento verso la quale la caratterizza qualità morali individuale. Il coraggio è una scelta consapevole in una situazione in cui il comportamento virtuoso può essere pagato solo rischiando la propria vita. «Chi si lancia sensatamente al pericolo per il bene e non ne ha paura, è coraggioso, e questo è coraggio» (MM. 1191 a 24). Come tipiche e naturali, tali situazioni sono associate a battaglie militari; il coraggio come virtù etica e la guerra come atteggiamento sociale sono reciprocamente correlati tra loro. Il coraggio può anche, secondo Aristotele, essere definito come un modo eticamente degno di comportamento umano in battaglia; da qui l'idea di essa come virtù maschile (la parola greca corrispondente, come il russo “coraggio”, ha la stessa radice delle parole “marito”, “uomo”). Sebbene il coraggio sia un incrocio tra paura e coraggio folle, è più vicino al coraggio, quindi agisce come capacità di sopportare la sofferenza, soprattutto il dolore fisico. Ci sono motivazioni e comportamenti corrispondenti che sono molto simili al coraggio e spesso vengono addirittura considerati tali, ma tuttavia non lo sono nel vero senso della parola. Secondo Aristotele ce ne sono cinque: a) coraggio civile, quando il superamento dei pericoli della guerra è stimolato dal timore del disonore o di una possibile punizione; b) esperienza, quando il comportamento efficace in battaglia è causato semplicemente dall'abilità e dalle qualifiche del guerriero; c) rabbia, quando il confronto con il pericolo è puramente affettivo; d) arroganza, spesso derivante da precedenti vittorie e simile all'arroganza dell'ebbrezza; d) ignoranza del pericolo. In tutti questi casi il superamento della paura della morte è dovuto a ragioni esterne alla virtù; Essi, sebbene stimolino un comportamento coraggioso entro certi limiti, tuttavia non lo garantiscono. Una persona coraggiosa affronta i pericoli in nome di un bellissimo obiettivo e considera questo modo di comportarsi di per sé virtuoso; Per lui il coraggio ha un valore intrinseco ed è motivo sufficiente di comportamento.
Il coraggio è una delle virtù centrali dell’ethos aristocratico, che era dominante nei costumi sociali dell’antichità e del Medioevo. Autorizza eticamente attività militari come una funzione importante delle classi privilegiate (ad esempio, in stato ideale Il coraggio di Platone è una specifica virtù custode). Durante tutta l’era pre-borghese, la concezione aristotelica del coraggio rimane generalmente accettata, e il coraggio stesso conserva lo status di una delle virtù cardinali. Con il passaggio dall'antichità greca all'antichità romana, più marziale che spirituale, aumenta ancora l'importanza del coraggio; in uno dei suoni latini (virtus) diventa contemporaneamente sinonimo di valore e virtù. Il coraggio è la virtù centrale dell’etica cavalleresca medievale, strettamente associata al concetto di onore. Un alto apprezzamento del coraggio è caratteristico anche della moralità del filisteismo, anche se qui non è più considerato una virtù cardinale e perde l'importanza primaria del valore militare.
La svalutazione e la trasformazione del concetto di coraggio divennero una delle espressioni e dei risultati più importanti di un cambiamento nei costumi sociali, durante il quale, secondo F. Nietzsche, "lo spirito industriale trionfò sullo spirito militare e aristocratico" ("Oltre il bene e il Male”, § 239). Secondo questo cambiamento, il coraggio diventa un tema secondario nell’etica filosofica della New Age. Hobbes nega ad essa lo status di virtù civica e considera la paura della morte come una forza produttiva che contribuisce all'instaurazione della pace. In Spinoza si colloca quasi alla fine del vasto catalogo degli affetti (“Etica”, parte III. Definizione degli affetti). Kant definisce il concetto di coraggio come la capacità di resistere al nemico del modo di pensare morale in noi stessi, cioè alle inclinazioni; essere coraggioso è osare ciò che il dovere impone. Crede che ci siano pericoli che richiedono più coraggio per essere superati che combattere in una battaglia o in un duello (ad esempio, la paura associata al ridicolo, alla derisione). Gli sforzi di Nietzsche per riportare il coraggio ai livelli superiori della gerarchia etica e ripristinare la sua comprensione originaria come virtù di un guerriero aristocratico rimasero solitari. Attualmente, il concetto è più spesso usato in senso ampio - come sinonimo di fermezza morale, forza d'animo di fronte a prove difficili, nonché di tale determinazione nel sostenere convinzioni morali che non tiene conto delle possibili perdite (non solo fisiche, ma anche materiale, sociale, psicologico). Si perde sempre più il significato della virtù maschile. Lo spostamento di enfasi nella comprensione del coraggio è notevolmente facilitato dalle moderne teorie e dalle esperienze pratiche della nonviolenza, in cui la lotta nonviolenta contro il male e l’ingiustizia è interpretata come più coraggiosa che violenta (secondo Gandhi, il coraggio della nonviolenza è molte volte maggiore che il coraggio della violenza). Anche il contenuto del concetto sta subendo cambiamenti: nel rapporto tra paure interne e pericoli esterni la proporzione dei primi aumenta.
Illuminato.; Aristotele. Etica Nicomachea.- Nel libro: Aristotele. Operazione. In 4 volumi, vol. 4. M., 1984: Platone. Lachete.- Nel libro: Platone. Dialoghi. M., 1986; Cicerone. Sui doveri (I). - Nel libro: Cicerone. Della vecchiaia, dell'amicizia, delle responsabilità. M., 1974; Tillich P. Il coraggio di essere - Nel libro: Tillich P. Preferiti. Teologia della cultura. M., 1995; Ossovskaya M. Cavaliere e borghese. M., 1988.
Ottima definizione
Definizione incompleta ↓