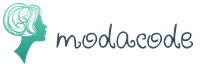Telegramma del ministro degli Esteri giapponese Ushida
(estrazione)
Il 27 marzo 1933 il governo giapponese annunciò il ritiro del Giappone dalla Società delle Nazioni. Pertanto, il Giappone ha intrapreso apertamente la strada dello scatenamento della Seconda Guerra Mondiale.
Segretario generale della Società delle Nazioni
Il governo giapponese ha attirato più volte l’attenzione su questo fatto e ha insistito sul fatto che la Cina non è uno Stato organizzato, bensì lo è posizione interna e le relazioni esterne sono caratterizzate da un'estrema vaghezza e complessità, nonché da numerose caratteristiche anormali ed eccezionali, e questo di conseguenza principi generali e costumi legge internazionale, che regola le ordinarie relazioni tra le nazioni, dovrà essere significativamente modificata se applicata alla Cina, il che spiega Politiche internazionali, completamente anormale e l'unico del suo genere operante in questo paese.
Tuttavia, la maggioranza dei leghisti si è mostrata incapace, durante le deliberazioni degli ultimi 7 mesi, né di comprendere questa realtà né di anticiparla e affrontarla adeguatamente. Inoltre, queste discussioni hanno spesso dimostrato che esistevano gravi divergenze di opinione tra il Giappone e le potenze in questione sull’applicazione e persino sull’interpretazione dei vari doveri e obblighi dell’ordine internazionale, compreso lo Statuto della Lega e i principi del diritto internazionale. Ecco perché il rapporto adottato dall’Assemblea nella Sessione Straordinaria del 24 febbraio, che ignora completamente i punti di partenza del Giappone, ispirato esclusivamente dal desiderio di mantenere la pace in Oriente, contiene gravi errori, sia nell’esposizione dei fatti che nella formulazione conclusioni che si traggono da questi fatti. Pur affermando che la condotta dell'esercito giapponese durante l'incidente del 18 settembre e successivamente non poteva essere considerata una difesa necessaria, il rapporto non fornì alcuna ragione per questa affermazione e raggiunse una conclusione arbitraria; e altrettanto omettendo di riconoscere lo stato di tensione delle relazioni che ha preceduto l’incidente in questione, così come le varie complicazioni che lo hanno accompagnato e di cui la Cina è interamente responsabile, il rapporto crea una nuova fonte di conflitto nell’arena politica dell’Est . Rifiutando di riconoscere le reali circostanze che hanno portato alla creazione del Manchukuo e cercando di contestare la posizione assunta dal Giappone riconoscendo il nuovo Stato, il rapporto impedisce la stabilizzazione della situazione in Estremo Oriente. Allo stesso modo, le disposizioni contenute nelle proposte non potranno mai, come spiega dettagliatamente il memorandum del governo giapponese del 25 febbraio scorso, contribuire in alcun modo all’instaurazione di una pace duratura in queste aree.
Si deve quindi concludere che la maggioranza dei leghisti, nel cercare una soluzione alla questione, hanno attribuito più importanza a formule inapplicabili che al dovere reale di assicurare la pace, e hanno cercato più di assicurare il trionfo delle tesi accademiche che di distruggere i germi di futuri conflitti. È per questa ragione, e a causa delle profonde divergenze di opinione che esistono tra il Giappone e la maggioranza dei membri della Lega riguardo all’interpretazione del Patto e di altri trattati, che il governo giapponese è stato costretto a rendersi conto che una differenza inconciliabile Le opinioni divergono tra il Giappone e la Lega nel campo della politica di pace, soprattutto per quanto riguarda i principi fondamentali da seguire per instaurare una pace duratura in Estremo Oriente. Il Governo giapponese, convinto che in queste circostanze è impossibile continuare la cooperazione, notifica preliminarmente, come richiesto dall'articolo 1, paragrafo 3, dello Statuto dell'intenzione del Giappone di recedere dalla Società delle Nazioni.
“Raccolta di documenti sulla politica internazionale e sul diritto internazionale”, M., 1934, pp. 226 - 227.
diplomatici giapponesi lasciando la Società delle Nazioni dopo l'annuncio del ritiro del Giappone da questa organizzazione. 1933
In precedenza, la delegazione giapponese aveva lasciato in modo dimostrativo la sala riunioni della Lega.
La registrazione del film di questo momento è qui sotto.
Il ritiro del Giappone dalla Società delle Nazioni fu il risultato dell'intervento giapponese in Manciuria e della sua successiva condanna da parte della Società delle Nazioni.
Le circostanze dell'intervento furono oggetto di un'indagine da parte di una commissione della Società delle Nazioni presieduta da Victor Bulwer-Lytton, che nella sua conclusione dichiarò il Giappone un paese aggressore.
“La conclusione finale della commissione ha dichiarato che tutte le azioni giapponesi erano un’aggressione pianificata e che la Manciuria è stata riconosciuta come territorio della Cina. Inoltre, la dichiarazione giapponese secondo cui la Cina è uno stato disorganizzato non è stata riconosciuta Manciù- È stato creato per volontà del Giappone stesso, ma senza la volontà delle persone che vivono in questo territorio, il Giappone è stato riconosciuto come un violatore. trattati internazionali e la Carta della Società delle Nazioni.
In conclusione, la commissione ha descritto le condizioni che, a suo avviso, dovrebbe soddisfare qualsiasi soluzione accettabile ai problemi emersi e ha proposto varie opzioni per accordi. Pertanto, è stato proposto di internazionalizzare il problema della Manciuria, per risolvere questo problema nel quadro della dottrina “ porte aperte", tenendo conto degli interessi del Giappone, dell'URSS e della Cina.
Di conseguenza, nel novembre 1932, questo rapporto Lytton fu presentato al Consiglio della Società delle Nazioni a Ginevra. Durante questo processo, il rapporto non fu approvato dalla parte giapponese e si decise, su iniziativa della Gran Bretagna, di sottoporlo per discussione al “Comitato dei 19” per monitorare lo sviluppo della questione della Manciuria.
Tuttavia, il rapporto non nomina direttamente il colpevole degli eventi accaduti in Manciuria. Nonostante i membri della commissione fossero unanimi nel ritenere che la colpa fosse della parte giapponese, su insistenza del rappresentante francese, il Giappone non fu nominato aggressore. Per mantenere un equilibrio tra contraddittorio diversi approcci delle parti, il rapporto, pur ripetendo il punto di vista giapponese sulla responsabilità della parte cinese, affermava allo stesso tempo che le azioni dell'esercito imperiale giapponese non possono essere considerate legittima difesa. Per quanto riguarda il Manchukuo, il rapporto indica che lo Stato non avrebbe potuto essere creato senza la presenza delle truppe giapponesi, che non è stato sostenuto dai cinesi e che la sua creazione non è stata il risultato della volontà naturale del popolo.
L'annuncio ufficiale del Rapporto Lytton era previsto per il 2 ottobre 1932, ma a settembre il Giappone annunciò il riconoscimento diplomatico del Manciukuo. Dopo che durante la riunione è stato annunciato il rapporto Litton Assemblea generale Lega delle Nazioni, quando l’opinione generale cominciò a propendere per dichiarare il Giappone un aggressore, la delegazione giapponese, guidata dall’ambasciatore Yosuke Matsuoka, lasciò le sue riunioni nel febbraio 1933. Il 27 marzo 1933 il Giappone annunciò ufficialmente il suo ritiro dalla Società delle Nazioni.
Il governo giapponese ha più volte attirato l’attenzione su questo fatto e ha insistito sul fatto che la Cina non è uno Stato organizzato, che la sua situazione interna e le sue relazioni estere sono caratterizzate da un’estrema incertezza e complessità, nonché da numerose caratteristiche anormali ed eccezionali, e che, come conseguenza Di conseguenza, i principi generali e le consuetudini dei diritti internazionali che regolano le relazioni ordinarie tra le nazioni devono essere notevolmente modificati quando applicati alla Cina, il che spiega la politica internazionale, del tutto anormale e unica nel suo genere, in vigore in quel paese.
Tuttavia, la maggioranza dei leghisti si è mostrata incapace, durante le deliberazioni degli ultimi 7 mesi, né di comprendere questa realtà né di anticiparla e affrontarla adeguatamente. Inoltre, queste discussioni hanno spesso dimostrato che esistevano gravi divergenze di opinione tra il Giappone e le potenze in questione sull’applicazione e persino sull’interpretazione dei vari doveri e obblighi dell’ordine internazionale, compreso lo Statuto della Lega e i principi del diritto internazionale. Ecco perché il rapporto adottato dall’Assemblea nella Sessione Straordinaria del 24 febbraio, che ignora completamente i punti di partenza del Giappone, ispirato esclusivamente dal desiderio di mantenere la pace in Oriente, contiene gravi errori, sia nell’esposizione dei fatti che nella formulazione conclusioni che si traggono da questi fatti. Pur affermando che la condotta dell'esercito giapponese durante l'incidente del 18 settembre e successivamente non poteva essere considerata una difesa necessaria, il rapporto non fornì alcuna ragione per questa affermazione e raggiunse una conclusione arbitraria; e altrettanto omettendo di riconoscere lo stato di tensione delle relazioni che ha preceduto l’incidente in questione, così come le varie complicazioni che lo hanno accompagnato e di cui la Cina è interamente responsabile, il rapporto crea una nuova fonte di conflitto nell’arena politica dell’Est . Rifiutando di riconoscere le reali circostanze che hanno portato alla creazione del Manchukuo e cercando di contestare la posizione assunta dal Giappone riconoscendo il nuovo Stato, il rapporto impedisce la stabilizzazione della situazione in Estremo Oriente. Allo stesso modo, le disposizioni contenute nelle proposte non potranno mai, come spiega dettagliatamente il memorandum del governo giapponese del 25 febbraio scorso, contribuire in alcun modo all’instaurazione di una pace duratura in queste aree.
Si deve quindi concludere che la maggioranza dei leghisti, nel cercare una soluzione alla questione, hanno attribuito più importanza a formule inapplicabili che al dovere reale di assicurare la pace, e hanno cercato più di assicurare il trionfo delle tesi accademiche che di distruggere i germi di futuri conflitti. È per questa ragione, e a causa delle profonde divergenze di opinione che esistono tra il Giappone e la maggioranza dei membri della Lega riguardo all’interpretazione del Patto e di altri trattati, che il governo giapponese è stato costretto a rendersi conto che una differenza inconciliabile Le opinioni divergono tra il Giappone e la Lega nel campo della politica di pace, soprattutto per quanto riguarda i principi fondamentali da seguire per instaurare una pace duratura in Estremo Oriente. Il Governo giapponese, convinto che in queste circostanze è impossibile continuare la cooperazione, notifica preliminarmente, come richiesto dall'articolo 1, paragrafo 3, dello Statuto dell'intenzione del Giappone di recedere dalla Società delle Nazioni.
Uscita della Germania dalla Società delle Nazioni
Lettera del ministro degli Esteri tedesco von Neurath
segretario generale Lega delle Nazioni Avenol
A nome del governo tedesco, ho l'onore di informarvi che la Germania dichiara il suo ritiro dalla Società delle Nazioni ai sensi del paragrafo 3, art. I dello Statuto.
Ingresso dell'URSS nella Società delle Nazioni
Lettera del commissario del popolo per gli affari esteri dell'URSS M.M. Litvinov al Presidente della XV Assemblea della Società delle Nazioni (15 settembre 1934)
Signor Presidente,
Il governo sovietico ha ricevuto un telegramma firmato da un numero significativo di membri della Società delle Nazioni, vale a dire: Unione del Sud Africa, Albania, Australia, Austria, Gran Bretagna, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Spagna, Estonia, Etiopia, Francia, Grecia, Haiti, Ungheria, India, Iraq, Italia, Lettonia, Lituania, Messico, Nuova Zelanda, Persia, Polonia, Romania, Cecoslovacchia, Turchia, Uruguay e Jugoslavia, nelle quali, sottolineando sia che il compito della Lega di Le nazioni devono organizzare la pace e poiché ciò richiede la cooperazione comune di tutti i popoli in questa questione, invitano l'URSS ad aderire alla Società delle Nazioni e a portare la loro cooperazione. Allo stesso tempo, il governo sovietico venne ufficialmente informato dai governi di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia del loro atteggiamento favorevole nei confronti dell’adesione dell’URSS alla Lega.
Il governo sovietico, che stabilì compito principale la sua politica estera, organizzando e rafforzando la pace e non è mai rimasto sordo alle proposte di cooperazione internazionale, nell'interesse della pace... è pronto a rispondere ad esso (invito) e diventare membro della Società delle Nazioni.
La risposta del governo sovietico
Su invito di un gruppo di potenze ad aderire alla Società delle Nazioni
Il governo sovietico ricevette un numero significativo di membri della Società delle Nazioni, vale a dire dell'Unione del Sud Africa, Albania, Australia, Austria, Gran Bretagna, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Spagna, Estonia, Abissinia, Francia, Grecia , Haiti, Ungheria, India, Iraq, Italia, Lettonia, Lituania, Messico, Nuova Zelanda, Persia, Polonia, Romania, Cecoslovacchia, Turchia, Uruguay e Jugoslavia, in cui, sottolineando che la missione della Società delle Nazioni è l'organizzazione della pace e che ciò richiede la cooperazione di tutti gli Stati, invitano l’URSS ad aderire alla Società delle Nazioni e a portare la loro collaborazione. Allo stesso tempo, il governo sovietico venne ufficialmente informato dai governi di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia del loro atteggiamento favorevole nei confronti dell’adesione dell’URSS alla Lega.
Considerando che tale appello, rivolto dalla stragrande maggioranza dei membri della Lega, rappresenta la reale volontà di pace della Lega e il riconoscimento della necessità di cooperazione con l'URSS, il governo sovietico, che pone l'organizzazione e il rafforzamento della pace come obiettivo principale compito della sua politica estera e non è mai rimasto sordo alle proposte di cooperazione internazionale nell’interesse della pace, è pronto a dare ascolto all’appello ricevuto e ad aderire alla Lega, prendendone il posto che le spetta, e ad accettare il rispetto dei conseguenti obblighi internazionali e le decisioni vincolanti per i membri della Società ai sensi dell'articolo 1 della Carta della Società delle Nazioni. Il governo sovietico è particolarmente soddisfatto del fatto che il suo ingresso nella Società delle Nazioni coincida con l'esame da parte della Società delle Nazioni della questione dell'armonizzazione dello statuto della Società con il Patto Kellogg-Briand, che vieta la guerra. Notando che gli articoli 12 e 13 del Patto prevedono la discrezionalità degli Stati nel ricorrere all'arbitrato e alla risoluzione giudiziale delle questioni, il governo sovietico ritiene necessario chiarire ora che, a suo avviso, i conflitti che si riferiscono a fatti accaduti prima del suo ingresso nella Lega non devono essere soggetti a modalità regolamentari designate.
Mi permetto di esprimere l'auspicio che questa dichiarazione venga accettata da tutti i membri della Lega nello stesso spirito di sincero desiderio di cooperazione internazionale e di garanzia della pace per tutti i popoli nei quali è stata fatta.
Società delle Nazioni e crisi internazionali degli anni '30
Crisi per l'aggressione giapponese in Manciuria
Nella notte tra il 18 e il 19 settembre 1931, le truppe giapponesi occuparono Mukden e iniziarono a catturare la Manciuria, che segnò l'inizio della formazione di un focolaio di guerra in Estremo Oriente.
Rapporto Lytton
Dopo che l'incidente di Shanghai fu risolto attraverso l'accordo di cessazione delle ostilità del maggio 1932, la Società delle Nazioni rivolse la sua attenzione alla preparazione e alla presentazione del rapporto della Commissione Lytton sugli eventi della Manciuria. Non ha intrapreso alcuna azione in relazione al riconoscimento del Manchukuo da parte del Giappone.
L'incarico di Lytton arrivò a Tokyo nel febbraio 1932, cioè prima che il Giappone dichiarasse il riconoscimento del Manciukuo. Da Tokyo, la commissione si è recata prima a Shanghai, Nanchino e Pechino, e in aprile è arrivata in Manciuria. A giugno è tornata a Pechino e ha iniziato a redigere il rapporto. Il 30 settembre questo rapporto è stato consegnato al Giappone e alla Cina e pubblicato il 2 ottobre.
Il rapporto rilevava che le azioni militari intraprese dal Giappone non potevano essere considerate legali e necessarie dal punto di vista dell'autodifesa. Inoltre, ha sottolineato che, sebbene non si possa ritenere che lo Stato del Manciukuo sia stato creato come risultato di un movimento indipendentista genuino e sorto in modo indipendente, tuttavia, data la situazione particolare che si è sviluppata in Manciuria, è impossibile ritornare meccanicamente allo stato cosa c'era in Manciuria fino al 18 settembre.
La relazione avanzata i seguenti principi risoluzione della questione della Manciuria: 1) soddisfazione degli interessi di Cina e Giappone; 2) tenere conto degli interessi Unione Sovietica; 3) riconoscimento degli accordi multilaterali esistenti; 4) riconoscimento degli interessi giapponesi in Manciuria; 5) instaurazione di nuovi rapporti contrattuali tra Cina e Giappone; 6) adottare misure efficaci per risolvere i conflitti futuri; 7) istituzione dell'autonomia per la Manciuria; 8) garanzia della sicurezza sia interna che esterna della Manciuria; 9) promuovere il riavvicinamento economico tra Cina e Giappone; 10) cooperazione internazionale nella ricostruzione della Cina (57). Il rapporto propone inoltre di creare organi amministrativi speciali nelle province di Mukden, Jilin e Heilongjiang e di garantire la sicurezza pubblica in quest'area con l'aiuto di distaccamenti di gendarmeria che non appartengano alle forze armate, nominando stranieri in posizioni di consiglieri del governo autonomo, nonché a incarichi di funzionari finanziari, ispettori e principali consiglieri della Banca Centrale.
Il rapporto di Lytton rifletteva il desiderio degli stati imperialisti di stabilire il controllo sulla Manciuria controllo internazionale. Allo stesso tempo conteneva molte disposizioni volte a “pacificare” il Giappone.
Nel mese di novembre si è tenuta a Ginevra una riunione del Consiglio della Società delle Nazioni, nella quale è stato discusso il rapporto Lytton. All'incontro erano presenti il rappresentante del Giappone Matsuoka Yesuke e il rappresentante della Cina Gu Wei-jun. Matsuoka sostenne che le azioni del Giappone erano motivate da considerazioni di autodifesa, che il movimento indipendentista del Manciukuo sorse in modo del tutto indipendente e si oppose alla proposta di utilizzare il Rapporto Lytton come base per risolvere la questione della Manciuria. Il rappresentante cinese Gu si è opposto alla proposta di Matsuoka.
La questione fu poi deferita all'Assemblea della Società delle Nazioni. Le riunioni dell'Assemblea sono iniziate a dicembre. I rappresentanti delle quattro grandi potenze - Inghilterra, Francia, Germania e Italia - hanno cercato di assumere una posizione conciliante nei confronti del Giappone. Tuttavia, a differenza di loro, i rappresentanti di piccoli paesi come Svezia, Norvegia, Irlanda e Cecoslovacchia chiesero il rispetto dei principi della Carta della Società delle Nazioni e insistettero sul non riconoscimento delle azioni giapponesi in Manciuria.
Al termine della discussione generale, il rappresentante della Cina, sottolineando che il conflitto sino-giapponese si è già trasformato in una lotta del Giappone contro l'intero mondo civilizzato, ha approvato le principali disposizioni del rapporto Lytton. In risposta, il rappresentante giapponese ha affermato che la Manciuria era un'area vitale per il Giappone. Sottolineando il pericolo di un'invasione comunista della Cina, ha sottolineato che il Giappone non dovrebbe essere indebolito, accelerando così il collasso dell'Estremo Oriente.
Il rappresentante giapponese minacciò che se il punto di vista dei piccoli paesi fosse stato accettato, il Giappone si sarebbe ritirato dalla Società delle Nazioni. Poiché l'Assemblea non è giunta ad alcuna decisione, la questione sino-giapponese è stata deferita alla Commissione dei Diciannove. Tuttavia, anche il Giappone si è opposto al progetto proposto da questa commissione.
L'Inghilterra continuò a perseguire una politica di pacificazione nei confronti del Giappone, fungendo da mediatore tra questo e la Società delle Nazioni. All'inizio di gennaio 1933 ebbe luogo un incontro tra l'ambasciatore britannico e il ministro degli Esteri giapponese Uchida. Quindi il segretario generale della Società delle Nazioni Dormont (Inghilterra) e il suo vice Sugimura Yotaro (Giappone) hanno redatto il loro progetto e lo hanno presentato informalmente al Giappone.
Questa bozza limitava significativamente l’uso delle proposte contenute nel Rapporto Lytton ed escludeva frasi come “non riconoscimento del Manciukuo”, che rappresentava la massima concessione al Giappone da parte della Società delle Nazioni. In Giappone le reazioni al progetto sono state diverse: mentre il gruppo Jushin insisteva per il suo riconoscimento, il governo prendeva una posizione ferma, dichiarando che il progetto necessitava di modifiche e integrazioni.
Nel frattempo, l'esercito giapponese si stava preparando a ritmo accelerato per conquistare la provincia di Zhehe. Dopo aver occupato le province di Mukden, Jilin e Heilongjiang, le truppe giapponesi iniziarono un'offensiva nella Cina occidentale. Nel luglio 1932, l'esercito giapponese, con il pretesto che un ufficiale giapponese era scomparso vicino alla città di Beipiao, nella provincia di Zhehe, lanciò un attacco a questa provincia. L'offensiva giapponese, proseguita per tutto luglio e agosto, è stata fermata dall'esercito cinese. Quindi il comando dell'esercito giapponese, dichiarando che "la provincia di Rehe è il territorio del Manciukuo", iniziò a concentrare qui le sue truppe. Nel gennaio 1933, approfittando dell'esplosione di una bomba a Shanhaiguan, le truppe giapponesi catturarono la città e chiesero la creazione di una zona cuscinetto nell'area di Shanhaiguan. Pertanto, nella provincia di Zhehe si è creata una situazione minacciosa.
Il 20 febbraio, il comando dell'esercito giapponese, a nome del governo del Manciukuo, ha inviato una nota al comando dell'esercito cinese chiedendo il ritiro delle truppe cinesi dal territorio della provincia di Zhehe. Successivamente, le truppe giapponesi lanciarono un nuovo attacco alla provincia di Zhehe.
Il ritiro del Giappone dalla Società delle Nazioni
L'incidente di Shanhaiguan e la nuova offensiva giapponese nella provincia di Rehe costrinsero la Società delle Nazioni ad assumere una posizione più forte. Nello stesso Giappone, i Jushin credevano che fosse meglio ritardare la cattura di Zhehe ed evitare di lasciare la Società delle Nazioni. Tuttavia, i militari non condividevano questo punto di vista, ritenendo che con il ritiro del Giappone dalla Società delle Nazioni sarebbe stato possibile effettuare facilmente un'aggressione contro la Cina.
Poiché la parte cinese ha protestato contro il progetto di conciliazione Dormont-Sugimura, e anche durante il colloquio tra l'ambasciatore britannico e il ministro degli Esteri giapponese Uchida, il governo giapponese ha assunto una posizione intransigente, la situazione nella Società delle Nazioni cambiato radicalmente. Ora la Società delle Nazioni ha deciso di non fare concessioni al Giappone. In questo momento, Hitler, dopo aver catturato potere politico in Germania, ha cominciato a chiedere l’eliminazione dello status quo, cosa che ha spinto anche la Lega a prendere una posizione più forte e a difendere la sua Carta.
La Società delle Nazioni ha fatto un passo avanti rispetto al periodo in cui cercava di raggiungere un accordo tra Giappone e Cina. È stata sviluppata una raccomandazione che proponeva di utilizzare il rapporto Lytton come base per risolvere il conflitto sino-giapponese. Il 24 dicembre questa raccomandazione è stata discussa all'Assemblea della Società delle Nazioni.
A questo proposito, in Giappone si diffuse la richiesta di ritiro dalla Società delle Nazioni. Anche il ministro della Guerra Araki e il ministro degli Esteri Uchida hanno insistito su questo punto. Anche lo Jushin, che prima si era opposto all'uscita dalla Lega, ora ha adottato questo punto di vista.
Nella riunione dell'Assemblea della Società delle Nazioni, tenutasi il 24 dicembre, il rapporto di Lytton è stato approvato a maggioranza: 42 delegati hanno votato a favore, uno contrario. A questo proposito, il rappresentante giapponese Matsuoka ha affermato che "gli sforzi del governo giapponese volti a cooperare con la Società delle Nazioni nella risoluzione del conflitto sino-giapponese hanno raggiunto il limite" e ha lasciato con aria di sfida la sala della riunione.
In connessione con l'approvazione del rapporto Lytton da parte dell'Assemblea, in Giappone è stata rilasciata una dichiarazione in cui si afferma che "il governo giapponese ritiene che né le azioni delle truppe giapponesi in Manciuria né la conclusione del protocollo Giappone-Manciù siano dirette contro la Società delle Nazioni o contro violare il Trattato delle Nove Potenze di Parigi e altri accordi internazionali." Inoltre, la dichiarazione sottolinea che “l’ascesa del comunismo in Cina è una questione di grande importanza per gli Stati europei e gli Stati Uniti; Rispetto ad esso tutti gli altri problemi perdono ogni significato. Allo stesso tempo la Manciuria, che ha interrotto completamente i suoi rapporti con la Cina, diventa una barriera contro il pericolo comunista in Estremo Oriente, e ogni uomo statista dovrebbe avere ben chiaro l’importanza della Manciuria da questo punto di vista. Parlando del pericolo comunista, il Giappone ha cercato di giustificare le sue azioni aggressive.
Il 28 marzo il Giappone ha annunciato il ritiro dalla Società delle Nazioni. Lo stesso giorno fu pubblicato l'editto imperiale. L’Imperatore ordinò che l’editto sottolineasse il seguente concetto: “Il Giappone è stato costretto a ritirarsi dalla Lega perché, sulla questione della Manciuria, il Giappone e la Società delle Nazioni, purtroppo, avevano punti di vista diversi e che questo atto del Giappone non è in contraddicono in alcun modo la linea principale della Società delle Nazioni: la preoccupazione per il bene dell'umanità." Successivamente, l'imperatore espresse ripetutamente pensieri simili riguardo al suo desiderio di collaborare con la Società delle Nazioni (58).
Anche se il desiderio dell'imperatore ebbe qualche effetto e parte del suo linguaggio fu usato nell'editto, era abbastanza chiaro che l'editto intendeva sopprimere qualsiasi critica al governo per il ritiro del Giappone dalla Società delle Nazioni. È stato il ritiro del Giappone dalla Lega a indicare che il paese si stava dirigendo verso l'isolamento internazionale. Allora la stampa udì solo invocazioni per l’attuazione di una “politica estera indipendente”; slogan come “Asia per gli asiatici”, “Voltiamo la faccia verso est” e altri cominciarono a dominare il paese.
Quando l'Ambasciatore Straordinario Matsuoka ritornò in Giappone, ebbe un incontro entusiasta (anche gli scolari vennero a salutare Matsuoka) – fu accolto come un eroe. Dicono che Matsuoka sia stato accolto nello stesso modo in cui è stato accolto Komura Jutaro (59) dopo la conclusione del Trattato di Portsmouth. Quando Matsuoka lasciò il Giappone, ricevette anche decine di migliaia di lettere di approvazione da parte del popolo giapponese, ma tra queste ce n’erano solo una o due, che contenevano il consiglio di “risolvere la questione in una sessione della Società delle Nazioni” (60 ). In una situazione del genere, un governo creato artificialmente dai militari e dal governo " opinione pubblica“Il governo stesso ha interrotto la propria strada verso la risoluzione della questione della Manciuria.
Posizione dei poteri
La situazione internazionale in Estremo Oriente era tale che al Giappone non fu fornita alcuna contromisura attiva. Dopo che la Società delle Nazioni ha approvato la raccomandazione poi presentata al Giappone e alla Cina (che è stata la ragione principale del ritiro del Giappone dalla Società delle Nazioni), è stato creato un comitato consultivo per sviluppare le misure che la Società delle Nazioni dovrebbe adottare.
La Società delle Nazioni chiese agli Stati Uniti e all'Unione Sovietica di partecipare ai lavori del comitato. Gli Stati Uniti accettarono l'invito e inviarono un osservatore al comitato, ma l'Unione Sovietica rifiutò di partecipare ai suoi lavori.
Nonostante il fatto che durante la riunione del comitato consultivo siano state sollevate domande sul divieto di esportazione di armi in Giappone e su come attuare la politica di non riconoscimento del Manciukuo, non è stato possibile attuare alcuna sanzione efficace contro il Giappone. Inoltre, anche dopo che il rappresentante cinese Gu è intervenuto in una sessione della Società delle Nazioni sulla questione della provincia di Zhehe sorta in quel momento, la Lega non ha intrapreso alcuna azione.
A questo proposito, il prestigio della Società delle Nazioni cominciò a diminuire. In seguito al fallimento della politica di pacificazione nei confronti del Giappone, perseguita dall’Inghilterra durante gli avvenimenti della Manciuria, quest’ultimo perse la sua autorità agli occhi della Cina, e il suo politica esteraè diventato inefficace. Anche gli Stati Uniti non riuscirono a presentare un fronte unito con l’Inghilterra e furono di fatto privati della possibilità di intraprendere qualsiasi azione.
Nel marzo 1933, il presidente repubblicano Hoover fu sostituito dal rappresentante del Partito Democratico Franklin Roosevelt. Hull ha sostituito Stimson come Segretario di Stato americano. La politica di Roosevelt in Estremo Oriente si riduceva a quanto segue. Considerando l'esperienza di Stimson, che protestò solo verbalmente e senza produrre alcun risultato, Roosevelt continuò a perseguire la precedente politica di non riconoscimento dell'aggressione giapponese in Manciuria, ma evitò di minacciare il Giappone e fece ogni sforzo per espandere Marina Militare STATI UNITI D'AMERICA. Allo stesso tempo, Franklin Roosevelt procedette dalla posizione espressa da Theodore Roosevelt: "Quando dici parole educate, non dimenticare la forza". Una delle ragioni della politica di pacificazione (almeno così sembrava) perseguita da Roosevelt era che lo sviluppo dell’industria pesante giapponese, iniziato dopo gli avvenimenti della Manciuria, creava un nuovo mercato per il capitale industriale americano, che attraversava una crisi durante questo periodo.
La cosa principale nella politica dell'Unione Sovietica in Estremo Oriente a quel tempo era il desiderio di evitare la creazione fronte unito potenze capitaliste contro l’URSS, l’URSS perseguì quindi una politica cauta nei confronti del Giappone (61). Ciò è dimostrato dai seguenti fatti.
Nel dicembre 1931 commissario del popolo Affari esteri Litvinov propose all'ambasciatore giapponese Yoshizawa Kenkichi, che stava tornando in Giappone in occasione della sua nomina a ministro degli affari esteri nel governo Inukai, di concludere un patto di non aggressione tra l'URSS e il Giappone, e nell'ottobre 1932 fece nuovamente , tramite l'ambasciatore giapponese in Unione Sovietica Hirota, ha proposto di concludere un simile accordo. Inoltre, l'Unione Sovietica propose di creare un consolato generale del Manciukuo a Mosca ed era pronta ad accettare che l'ambasciatore giapponese in URSS unisse le funzioni del console generale del Manciukuo; Anche l'URSS non si è opposta alla vendita del CER al prezzo adeguato.
Tuttavia, il governo giapponese, che ha proclamato la parola d'ordine della lotta contro il comunismo, ha respinto le proposte sovietiche, affermando che non era ancora giunto il momento di avviare negoziati formali. Tuttavia, l’Unione Sovietica non ha rinunciato alla speranza di migliorare le relazioni con il Giappone. Quando la Società delle Nazioni si rivolse all'Unione Sovietica chiedendo di partecipare ai lavori del comitato consultivo, Litvinov rifiutò l'offerta, citando il fatto che la maggioranza dei membri del comitato rappresentava stati ostili all'Unione Sovietica. Litvinov evitò quindi categoricamente di peggiorare le relazioni con il Giappone (62).
Nell'aprile 1933, le autorità del Manciukuo chiusero la comunicazione tra la Ferrovia Orientale Cinese e linee ferroviarie Unione Sovietica nell'area delle stazioni Manciuria e Pogranichnaya. Ma anche in questa situazione, l’URSS cercò di evitare l’inasprimento delle relazioni con il Giappone. Nel maggio 1933, il governo sovietico annunciò la sua disponibilità a cedere alla Ferrovia Orientale Cinese.
Nel mese di giugno sono iniziate le trattative per la vendita della CER; L’Unione Sovietica chiese di pagarle 250 milioni di rubli (1 rublo equivaleva a 1,04 yen); in agosto fece un'altra concessione, chiedendo 200 milioni di rubli per la CER, ma il Manchukuo insistette ostinatamente per 50 milioni di yen. Alla fine di settembre i negoziati erano in fase di stallo. Da questo momento in poi le relazioni nippo-sovietiche iniziarono gradualmente a deteriorarsi (63).
Eventi simili si sono sviluppati in Europa. Dopo aver instaurato la sua dittatura in Germania, Hitler nell'ottobre 1933 annunciò il ritiro della Germania dalla Società delle Nazioni e dal Comitato per la riduzione delle armi. A questo proposito, l’autorità della Società delle Nazioni è diminuita ancora di più. La politica di cooperazione internazionale ha fallito. Allo stesso tempo, la Conferenza di Ginevra sulla riduzione delle armi, convocata nel marzo 1933, fallì, così come la Conferenza economica di Londra, tenutasi nel giugno dello stesso anno. In connessione con il fallimento della conferenza economica, sulla scena internazionale si intensificarono le tendenze verso la formazione di blocchi economici e ovunque furono erette barriere doganali.
Tutto ciò, a sua volta, ha portato ad un aggravamento delle contraddizioni tra gli Stati.
Tregua a Tangu
All'inizio di marzo 1933, le truppe giapponesi avevano conquistato l'intera provincia di Zhehe. Il governo del Kuomintang ridusse la difesa della provincia di Jehe a un semplice ritardo per conquistare la Società delle Nazioni. Invece di organizzare la resistenza ai giapponesi, il capo del governo della provincia di Jehe, Tang Yu-lin, scelse di fuggire portando con sé le sue proprietà.
Il 10 marzo, le truppe giapponesi lanciarono un'offensiva generale lungo la Grande Muraglia cinese. In questa situazione, Chiang Kai-shek, che concentrò tutte le sue forze nella lotta contro l'Armata Rossa cinese, arrivò al nord. Qui si tenne un incontro al quale presero parte Chiang Kai-shek, Zhang Hsue-liang, Soong Tzu-wen e He Ying-qin, al termine del quale Zhang Hsue-liang, che aveva concentrato nelle sue mani tutto il potere politico nella Cina nordorientale, si ritirò dall'attività Tutto il potere politico e militare in quest'area passò a He Ying-qin. Quindi l'esercito fu riorganizzato Cina nord-orientale, comandato da Zhang Xue-liang.
Pertanto, il governo del Kuomintang estese la sua influenza sulla Grande Muraglia cinese, evitando spargimenti di sangue. Tuttavia, Chiang Kai-shek e He Ying-qin, timorosi di indebolire le loro forze, evitarono lo scontro diretto con le truppe giapponesi.
La 29a armata cinese si scontrò con l'esercito giapponese che, dopo aver lanciato una controffensiva vicino a Xifenkou, lanciò un attacco alla provincia di Zhehe. Ma Chiang Kai-shek e He Ying-qin ordinarono alle forze principali dell'esercito di ritirarsi sul fiume Luanhe, il che portò al suo isolamento e alla sconfitta. Successivamente, le truppe giapponesi, dopo aver attraversato il fiume Luanhe, lanciarono un attacco a Pechino e Tianjin. In una situazione del genere, elementi all’interno del governo del Kuomintang divennero più attivi e si espressero a favore di una soluzione alla situazione pacificando il Giappone e creando una “zona cuscinetto” nella Cina settentrionale.
Alla fine di maggio, grazie agli sforzi del famoso Huang Fu filo-giapponese, iniziarono i negoziati tra i comandi cinese e giapponese per porre fine alle ostilità. Il 31 maggio a Tangu è stato firmato un accordo corrispondente. Prevedeva il ritiro delle truppe cinesi dall'area a est del fiume Luanhe (a sud della Grande Muraglia cinese) e la trasformazione di quest'area in zona smilitarizzata. La polizia cinese è stata incaricata di garantire la sicurezza pubblica nella zona. Dopo l'evacuazione delle truppe cinesi dalla zona specificata, le truppe giapponesi avrebbero dovuto ritirarsi verso la Grande Muraglia cinese.
Ufficialmente l'accordo Tangu riguardava solo questioni militari, vale a dire la cessazione delle ostilità; di fatto, pose fine alle relazioni ostili tra Giappone e Cina, causate dagli eventi della Manciuria, e fece sì che la Cina accettasse la situazione che si era sviluppata in Manciuria (64).
Il fatto che questo accordo sia stato firmato a seguito di negoziati svoltisi direttamente tra i due paesi, senza la partecipazione della Società delle Nazioni, che ha proclamato il principio delle garanzie collettive, ha significato che l'autorità della Lega ha subito un altro duro colpo .
A giugno è stato creato un comitato speciale sotto l’esecutivo Yuan, guidato da Huang Fu, incaricato di garantire la pace e l’ordine nella “zona cuscinetto”. Il potere del comitato si estendeva alle province di Shandong, Shanxi, Hebei, Chahar, Suiyuan e alle città di Pechino e Qingdao. Ad agosto, l'esercito del Kwantung ha completato il ritiro delle sue truppe verso la Grande Muraglia cinese. L'esercito giapponese di stanza nel nord della Cina era composto da due battaglioni, ma dopo che si unì alla Brigata Mista Separata, le sue forze aumentarono in modo significativo.
In Cina, le forze insoddisfatte della politica conciliatrice del governo del Kuomintang iniziarono ovunque rivolte. Feng Yu-hsiang, Fang Cheng-wu e Ji Hong-chang formarono un esercito unito nella provincia di Chahar e invasero la zona smilitarizzata. Li Chi-shen e Tsai Ting-kai, capi della 19a armata, che si era glorificata nelle battaglie di Shanghai, formarono un governo popolare nel Fujian e invitarono il popolo alla lotta armata contro le truppe giapponesi. Tuttavia, il governo del Kuomintang ha schiacciato queste forze.
A partire da questo periodo, il governo del Kuomintang iniziò a perseguire una politica volta alla soppressione dell’Armata Rossa cinese e all’unificazione del paese sotto il governo del Kuomintang, basata sulla cooperazione di Chiang Kai-shek e Wang Ching-wei (65). Il governo del Kuomintang non rinunciò alla resistenza al Giappone e dichiarò verbalmente che nei confronti del Giappone aderiva al principio di “resistenza e negoziazione allo stesso tempo”, ma in realtà sosteneva il riavvicinamento con il Giappone.
Nel settembre 1933, alla Conferenza sul disarmo di Ginevra, le richieste tedesche cominciarono a farsi sentire nuovamente sulla necessità di riconoscere l'uguaglianza della Germania. La delegazione francese ha proposto di mantenere gli armamenti al livello raggiunto e di abbandonare sia il disarmo che il pre-armamento entro quattro o cinque anni. Allo stesso tempo, i francesi hanno insistito per l’adozione di un sistema di sanzioni contro i trasgressori della proposta di risoluzione.
Inghilterra e Italia rifiutarono di sostenere la proposta francese. Ma il rappresentante americano Norman Davis venne in sua difesa. Alla fine è stato raggiunto un accordo. Il 24 settembre 1933, in una riunione della Società delle Nazioni, una bozza di un nuovo trattato fu proposta al rappresentante tedesco, il barone von Neurath, a nome delle quattro potenze: Inghilterra, Francia, Italia e Stati Uniti. Stabilì due fasi di disarmo: in primo luogo, un periodo di stabilizzazione di tre o quattro anni, durante il quale la Germania avrebbe dovuto sostituire il suo sistema di servizio a lungo termine con uno a breve termine; anche la seconda fase dura dai tre ai quattro anni, durante i quali deve essere effettuato il disarmo vero e proprio.
La Germania rifiutò di accettare questo progetto, dichiarando di non voler più svolgere il ruolo di paria; se le verrà negata la parità di diritti, non parteciperà più alle conferenze internazionali.
Il 6 ottobre 1933 il governo tedesco indirizzò una nota ai governi britannico e italiano in cui affermava che accettare le proposte delle quattro potenze avrebbe significato una discriminazione, alla quale la Germania non poteva accettare. Il 13 ottobre Hitler riunì un gabinetto, convocò il presidente Hindenburg a Berlino e sollevò la questione del ritiro della Germania dalla Società delle Nazioni. Il giorno successivo, 14 ottobre, il governo tedesco annunciò il ritiro della Germania dalla Società delle Nazioni e dalla Conferenza sul disarmo. A questo proposito, Hitler sciolse il Reichstag con il decreto presidenziale di Hindenburg e fissò le elezioni generali per il 14 novembre.
Il 19 ottobre 1933 il segretario generale della Società delle Nazioni ricevette un breve telegramma dal ministro degli Esteri tedesco: “A nome del governo tedesco ho l’onore di informarvi che la Germania dichiara il suo ritiro dalla Società delle Nazioni , ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della Carta."
Il ritiro della Germania dalla Conferenza sul disarmo e il suo annuncio di ritiro dalla Società delle Nazioni hanno segnato una nuova tappa non solo nella politica tedesca, ma anche nella politica tedesca. ulteriori sviluppi relazioni internazionali. Il periodo delle conferenze, dei negoziati e degli accordi pacifisti è finito. La Germania nazista creò un focolaio di guerra in Europa.
Ingresso dell'URSS nella Società delle Nazioni e conclusione dei trattati di mutua assistenza
Il 18 settembre 1934, l'Assemblea della Società delle Nazioni, su iniziativa della diplomazia francese, decise di ammettere l'Unione Sovietica nella Lega e di dotarla di un seggio permanente nel Consiglio della Lega. Tre stati – Paesi Bassi, Portogallo e Svizzera – hanno votato contro questa decisione.
Dopo che i nazisti annunciarono l’introduzione della coscrizione universale in Germania nel marzo 1935, in Francia divenne predominante il desiderio di riavvicinamento all’Unione Sovietica. Anche una parte dei circoli tradizionalmente antisovietici, di mentalità patriottica, cominciò a chiedere un accordo con l'URSS.
Il 2 maggio 1935 fu firmato a Parigi il trattato di mutua assistenza tra l'URSS e la Francia. Le parti del trattato si sono impegnate a fornirsi immediatamente assistenza e sostegno reciproco in caso di attacco da parte di qualsiasi stato europeo. Il protocollo, firmato contemporaneamente all'accordo, ha sottolineato il desiderio di entrambe le parti di continuare a raggiungere la conclusione Accordo europeo sulle questioni di sicurezza. Il protocollo sottolineava inoltre che l’assistenza prevista dal trattato deve essere fornita in conformità con le raccomandazioni della Società delle Nazioni, ma se tale raccomandazione non viene fatta, allora “l’obbligo di assistenza sarà comunque adempiuto”.
In seguito all'accordo con la Francia, il 16 maggio 1935 l'Unione Sovietica firmò un accordo di mutua assistenza con la Cecoslovacchia dal contenuto simile. Secondo questo trattato, l'URSS era obbligata a venire in aiuto della Cecoslovacchia se la Francia avesse adempiuto ai suoi obblighi nei confronti di questo paese e fosse venuta in suo aiuto. Fu firmato il corrispondente patto cecoslovacco-francese. Tuttavia, la posizione della Francia non era coerente. In molti modi, continuò a seguire la linea della politica britannica, intesa a preservare la pace europea facendo concessioni agli aggressori. Era una politica di “pacificazione” Germania fascista. A causa della riluttanza della parte francese, la convenzione militare tra Francia e Unione Sovietica non fu firmata.
All’inizio del 1934, gli Stati Uniti d’America superarono la proporzione “Washington-Londra” in termini di armi navali. F. Roosevelt annunciò l'intenzione degli Stati Uniti di ritornare, tenendo conto delle nuove condizioni, al concetto wilsoniano di costruzione navale. A sua volta, il Giappone nel 1936 annunciò la denuncia dei trattati marittimi di Washington e Londra.
Alla fine del 1935 fu convocata a Londra una nuova conferenza delle cinque potenze sugli armamenti navali. Durante l'incontro, il Giappone, incoraggiato dalla firma dell'accordo navale anglo-tedesco nel maggio 1935, chiese l'uguaglianza negli armamenti navali con la Gran Bretagna e gli Stati Uniti e lasciò la conferenza dopo che queste richieste furono respinte. L’Italia fascista seguì l’esempio.
Il nuovo trattato navale, firmato nel marzo 1936 da USA, Gran Bretagna e Francia, mantenendo sostanzialmente la proporzione precedente, non prevedeva restrizioni quantitative nella costruzione di flotte militari. Nel mondo stava iniziando una nuova corsa agli armamenti navali.
Sotto la pressione dell'opinione pubblica, i governi di Inghilterra e Francia hanno concordato sulla necessità di convocare una conferenza internazionale sulle misure per combattere la pirateria marittima. Il 14 settembre 1937, a Nyon (Svizzera), nove stati - URSS, Inghilterra, Francia, Turchia, Grecia, Jugoslavia, Romania, Bulgaria ed Egitto - firmarono un accordo, secondo il quale ciascuno Sottomarino e gli aerei che attaccano le navi mercantili dovrebbero essere immediatamente attaccati e distrutti dalle navi da guerra dell'Inghilterra e della Francia. I governi interessati hanno distribuito tra loro la protezione marina in zone separate. Italia e Germania rifiutarono di partecipare alla conferenza. La Conferenza di Nyon e le sue decisioni hanno dimostrato la possibilità di proteggere con successo gli interessi degli Stati: la pirateria marittima è stata quasi completamente fermata.
RELAZIONI INTERNAZIONALI
DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE (1939-1945)
Inizio della guerra
Secondo Guerra mondiale, uno dei più grandi eventi storici, durò 6 anni, coprendo quasi tutti i continenti e tutti gli oceani. Alla guerra presero parte 61 stati, comprese tutte le grandi potenze, più dell'80% della popolazione globo, ha mobilitato fino a 110 milioni di persone. La sua portata superò di gran lunga quella della prima guerra mondiale.
Gli stati fascisti e militaristi, guidati da Germania, Italia e Giappone, si consideravano privati dei trattati del sistema Versailles-Washington e chiedevano “spazio vitale” a spese di altri stati, cercavano una nuova ridistribuzione del mondo, si impadronivano delle colonie, fonti di materie prime e mercati di vendita che allora erano prevalentemente sotto il controllo di Inghilterra, Francia, Stati Uniti e paesi collegati.
I più grandi stati fascisti-militaristi – Germania e Giappone – cercavano il dominio del mondo. I nazisti volevano stabilire un dominio indiviso in Europa, schiavizzare i popoli slavi, impadronirsi del territorio europeo dell'URSS fino agli Urali, impossessarsi del Vicino e Medio Oriente e ricreare un impero coloniale in Africa.
L’Italia cercò di conquistare l’Algeria, la Tunisia, l’Egitto, il Sudan e altri paesi, di trasformare il Mar Mediterraneo nel “Lago italiano” e di sottomettere i paesi della penisola balcanica.
Il Giappone intendeva conquistare la Cina e parti dell’Unione Sovietica, così come la Birmania, la Malesia, l’Indonesia, le Filippine e altri “paesi dei Mari del Sud”. Piani di guerra La Germania di Hitler, furono tenuti segreti anche ai loro più stretti alleati: Italia e Giappone. Innanzitutto era previsto un attacco alla Polonia.
Il 1° settembre 1939, con l’attacco tedesco alla Polonia, ebbe inizio la Seconda Guerra Mondiale. Inghilterra e Francia, vincolate dalla promessa di aiutare la Polonia, dichiararono guerra alla Germania il 3 settembre 1939. L'esempio della Gran Bretagna fu seguito dalla sua più grande colonia, l'India, e da tutti i domini inglesi: Canada, Unione del Sud Africa, Australia e Nuova Zelanda. L'Italia fascista, che non ebbe il tempo di completare i preparativi per la guerra, assunse la posizione di "alleato non combattente" della Germania. Il governo americano ha dichiarato la neutralità.
Il piano di guerra tedesco presupponeva che Gran Bretagna e Francia non avrebbero avviato un’azione militare attiva contro la Germania. Quindi avanti Fronte occidentale La Germania lasciò solo una debole barriera, lanciando le sue forze principali contro la Polonia. Dopo aver conquistato Varsavia il 28 settembre 1939 e aver soppresso le ultime sacche di resistenza dell'esercito polacco, le ostilità cessarono. La Polonia è stata sconfitta.
Informazioni correlate.